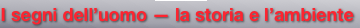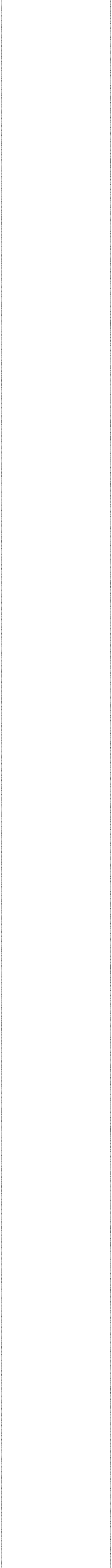
La porzione orientale del massiccio montuoso del Catria, lungo la dorsale minore del M. Roma (848 m) - M. Mura (898 m) – Castellaccio (525 m), già dal Settecento, per tutto l’Ottocento e fino alla prima metà del secolo scorso, era costellata da un gran numero di piccoli campi coltivati, denominati Cese o Ranchi. Questi appezzamenti erano insediati su terreni carbonatici, in un territorio, per quanto di quota non elevata, dalle caratteristiche tipicamente montane. Tutta l’area era gestita fin dal medioevo dalle Comunità o “Università degli Uomini Originari” di Frontone e Serra S. Abbondio, dapprima in qualità di affittuari (o livellari), in seguito come pieni proprietari.
L’Università o Consorzio degli Uomini originari di Serra S. Abbondio aveva affrancato una parte di tali beni nel 1839 e nel 1841 aveva adottato il primo Regolamento Amministrativo, che stabiliva i ruoli e le competenze organizzative, oltre ai criteri per la gestione e la “conservazione” di quei terreni: dei boschi o macchie, dei pascoli e delle Cese. I Capitoli 8° e 9° del Regolamento si occupavano appunto delle Cese, che erano così definite: “una parte di terreno circondata da siepi, posto nei monti del Consorzio, ridotto a coltura e a fieno, dagli Uomini Originari e particolari del Consorzio stesso”. Le Cese sorgevano, come il Regolamento più volte ricorda, “in luoghi alpestri, disabitati e montuosi”, l’ambiente circostante era costituito da boschi o “macchie” e da pascoli. Dunque uno dei caratteri specifici delle Cese era quello della loro netta divisione dai circostanti ambienti montani. Il Cap. 9° del Regolamento del Consorzio degli Uomini Originari di Serra S. Abbondio parlava inoltre delle “Siepi e delle Fratte”, che avevano il compito di recintare e difendere le Cese. “Il possessore d’ogni cesa per nota consuetudine antichissima, dovrà far la sua fratta con tre cinte e ligaturi intorno alle medesime in modo che siano atte ad impedire che i bestiami non vadino[sic] a recar danno”. Lo stesso Regolamento ricordava ancora: “Fatte che siano le siepi non potranno più rimuoversi, anzi dovranno mantenersi a riattarsi annualmente, sia che si tratti di siepe viva, o di siepe morta, ancorché l’utenza della cesa non la rinunciasse ed abbandonasse definitivamente. In questo modo li aventi non avranno potere di dilatarsi di anno in anno, come si pratica abusivamente, e di devastare le macchie per formare ogni anno la nuova fratta come hanno fatto fin ora”. Non diversi erano i Ranchi, come erano denominati gli stessi appezzamenti di terra dai vicini Frontonesi. Anche l’Università degli Uomini Originari di Frontone aveva ottenuto nel corso del XIX secolo l’affrancazione dei beni che gestivano fin dal medioevo. Nel 1852 si erano dotati del primo Regolamento ufficialmente riconosciuto, che venne poi stampato, con alcune aggiunte, nel 1873. Questo Regolamento si occupava anch’esso delle terre montane ridotte a coltura. Il Ranco era appunto recintato da: “siepe o muricciolo per proteggerlo da eventuali danni da parte di animali lasciati al pascolo”. Nel nuovo Regolamento dell’Università degli Uomini Originari di Frontone, del 1903, si specificava ancora: “I Ranchi affittati dovranno a cura degli affittuari medesimi essere recinti di mura o di siepe perché i proprietari dei bestiami mandati al pascolo non siano soggetti ad una scrupolosa custodia dei medesimi”.
Dentro le Cese e i Ranchi si effettuavano diverse coltivazioni, in genere di cereali ed erbe da foraggio. Esclusivamente su questi prodotti si esercitavano i diritti di possesso di chi le coltivava. Ricordava, a tale proposito, il Regolamento degli Uomini di Serra S. Abbondio: “Ogni possessore di cese, se queste sono a fieno, sarà soltanto padrone della prima erba della medesima, se sono a coltivazione sarà padrone del solo fruttato delle sue fatiche industriali, mai potrà avere alcun diritto al frutto degli alberi fossero nati naturalmente, ovvero esistessero nel recinto di tali cese, e molto meno sui frutti, rami, cespugli in quella esistenti, mentre la proprietà di tali piante spetterà sempre al Consorzio, con tutti li alberi e soprassuoli macchiosi di detti monti”.
Le Cese e i Ranchi fanno dunque parte della categoria dei terreni agricoli detti “campi chiusi”. In effetti però la loro chiusura era solo temporanea, incompleta in quanto limitata al periodo dell’anno sufficiente a sviluppare e portare a termine la produzione agricola che vi si effettuava, il cui termine, in genere, cadeva a metà estate: “...e precisamente fino alla metà del venturo agosto, essendo antichissimo costume che ogni particolare possessore debba, in tale epoca, aprire le cese e però deve conservarsi tale usanza a comodo dei bestiami che hanno diritto di pascervi, ed anche perché si conosca essere quello un terreno comune spettante al Consorzio”. Da una parte c’era la riaffermazione del diritto “antichissimo” di libero pascolo. Tanto antico che il Regolamento citava sostanzialmente un articolo dell’Editto di Rotari del 643. Non secondaria era la conferma che la totale proprietà del terreno spettasse comunque all’Ente, che era stato dapprima il Collegio Germanico-Ungarico di Roma e in seguito il Consorzio degli Uomini Originari, escludendo categoricamente ogni diritto di proprietà individuale e personale all’affittuario che lo chiudeva e lo coltivava.
A poter usufruire di Cese e Ranchi erano soprattutto le famiglie Originarie delle rispettive Università. Già nel 1807 un Editto del Conte della Porta di Frontone stabiliva di costituire l’elenco dei Ranchi e le modalità di concessione, dando diritto a chiunque di ottenerli, ma con priorità ai locali e in particolare agli Uomini Originari. Agli inizi del XX secolo, il Regolamento degli Uomini Originari di Frontone manteneva ancora questa disposizione: “I terreni (Ranchi) a coltivazione, i boschi per uso palo e frasca ed i prati per uso fieno saranno sempre dati in proporzioni possibilmente uguali in affitto ai condomini. Qualora nessun condomino richiedesse in affitto gli appezzamenti disponibili, questi potranno essere ceduti ad estranei...”. Per i confinanti Serrani non c’era sostanziale differenza, l’art 27° del loro Regolamento, stabiliva un’equa distribuzione delle Cese tra le famiglie originarie: “Ogni famiglia ha diritto di poter avere delle cese in detti monti, ma il riparto dovrà farsi in ragione dei bisogni di ciascuna famiglia, a giudizio della Congregazione; quindi è che se mai riconoscesse, che una qualche famiglia delle originarie godesse una quantità esorbitante di terreno ridotto a cese, il Prefetto, col parere della detta Congregazione ordinerà alla medesima di abonare[sic] una porzione, giacché diversamente vi sarebbero di quelle che avrebbero molto, mentre altre avrebbero ben poco, e di cattiva qualità, e forse anche niente”.
Una particolare attenzione dello stesso Regolamento era quella di impedire la creazione arbitraria di nuove Cese o l’allargamento di quelle esistenti: “...e ciò perché tollerandosi tali abusi si devastano soprassuoli e si rovinano affatto i terreni, mentre i primi si recidono ed il terreno, trattandosi di monte, viene dilavato dalle acque e rimane del tutto infruttifero”. Lo stesso problema era ancora sottolineato in un altro articolo: “le mentovate cese fatte a capriccio, hanno in gran parte devastato i terreni pascolativi macchiosi per circondarsi di siepi, hanno tolto non solo la strada ma pur anco i piccoli viali, che servivano a transitare i monti, e sino impedito il modo di andare i bestiami agli abeveratoi[sic], per cui i bestiami stessi trovando chiusi gli additi consueti, possono più facilmente pericolare, e con simili abusi furono ancora vietati da più consigli comunali e particolarmente da quello del 27 luglio 1800, le quali cese appunto dettero già motivo ai RR. PP. Amministratori del Collegio Germanico-Ungarico di Roma, di proclamare l’emenda dei danni e la caducità, delle quali giuste pretese i Serrani hanno pur dovuto redimersi con tanto dispendio”. Un’estrema attenzione veniva posta nella gestione delle Cese, alla base di queste limitazioni c’era dunque una chiara consapevolezza dell’impatto ambientale che tali appezzamenti coltivati producevano in un’area già naturalmente fragile, che inoltre si trovava in precario equilibrio tra le attività di prelievo della legna nei boschi e di avvio degli animali al pascolo, delle tradizionali attività economiche praticate da secoli.
Il richiamo ad editti dei primi dell’Ottocento e perfino alle cause legali che l’Università aveva avuto con i Reverendi Padri Gesuiti nel corso del secolo precedente, dove la questione delle Cese risultava centrale, dimostra l’antichità di questi appezzamenti coltivati. In effetti le più antiche notizia della presenza di “campi chiusi” nell’area del Catria si hanno, per il territorio di Cagli, ad iniziare dall’XI secolo; e, per la zona di Serra S. Abbondio, dalla fine del XII secolo. Più precisamente: nel territorio del castello di Campietro, nel 1197 (dunque prima della fondazione di Serra S. Abbondio), c'era "una clausura terra et vinea". Nello stesso anno inoltre esisteva già la località "qui dicitur Muri", che indicava con grande probabilità quello che oggi si chiama Monte Mura, toponimo dovuto presumibilmente al gran numero dei muri delle cese che vi sorgevano, muri tuttora presenti e ben visibili. Inoltre diversi nuclei fortificati, esistenti prima dell’avvento dei comuni di metà Duecento (che con il loro rivoluzionario sinecismo assorbirono i vecchi castelli causandone il progressivo declino), erano collocati proprio nel territorio di cui ci occupiamo. I medievali castelli di Capitale, Spicchio, Campietro e Leccia si trovavano a ridosso dell’area di diffusione delle Cese e dei Ranchi, anzi si può affermare che queste fossero in alcuni casi, come per Capitale e Spicchio, proprio i campi chiusi annessi ai relativi castelli. Un altro legame unisce poi i castelli di metà medioevo con le Cese, la modalità di fortificazione erano le stesse, per entrambi le chiusure erano costituite dal complesso: siepe spinosa- muro-fossato.
Ad iniziare dalla metà del XIII secolo questi piccoli castelli persero i loro ambiti amministrativi, le loro servitù e si svuotarono dei loro abitanti. Così Serra S. Abbondio assorbì i castelli di Campietro, che scomparve del tutto nell’arco di qualche secolo, e di Leccia, che si ridusse ad un villaggio privo di fortificazioni. Tuttavia questo declino fu probabilmente meno radicale per i loro campi chiusi, questi infatti vengono citati anche a fine medioevo insieme al particolare toponimo di “Paleare de feno”, che indicava, nel 1467, un punto di confine nei pressi dell’odierno crinale tra Civitella e Gingualdese (826-844 m), località che ancora oggi viene chiamata “Pajar del fieno”. Siamo al centro dei Ranchi de il Serrone e delle Cese del M. Mura, dove il taglio delle “prime erbe” verrà ammucchiato in pagliai di fieno per tutti i secoli seguenti.
Oggi gli stessi nomi, Cese e Ranchi, hanno perso ogni significato. Chi sale sulle montagne tra Frontone, Fonte Avellana, Serra S. Abbondio e Badia di Sitria trova solo un paesaggio pittoresco fatto di boschi e pascoli. Eppure del passato agricolo di questi territori c’è ancora qualche traccia. Prima di tutto mucchi di pietre, fossati e lunghi muriccioli, allineamenti geometrici di cespugli e alberi, tracciano, nei pascoli e tra i boschi più radi, i confini di una sorta di mosaico. I muretti sono quasi sempre abbattuti, i fossati parzialmente riempiti, sopra vi crescono cespugli infestanti... Infestanti? Non proprio, più esattamente si tratta delle stesse piante che i contadini ottocenteschi utilizzavano per chiudere le Cese e i Ranchi e i signori medievali per munire i loro castelli. Se andiamo presso i pochi ruderi del Castello di Capitale o tra i resti delle Cese di Pian di Serra troviamo ancora quella antica flora: prima di tutto le piante spinose: rose (Rosa canina compl., più raramente anche R. spinosissima e R. agrestis), rovi (Rubus sp.), asparagi selvatici (Asparagus acutifolius), prugnoli (Prunus spinosa), biancospini (Crataegus monogyna e più raram. C. laevigata), ginepri (sporadicamente sia Juniperus communis che J. deltoides) e agrifogli (Ilex aquifolium); poi ginestre (Spartium junceum), cornioli (Cornus mas), oppi o aceri campestri (Acer campestre), aceri minori (Acer monspessulanum), ciliegi canini (Prunus mahaleb), ciliegi (Prunus avium), roverelle (Quercus pubescens), ornielli (Fraxinus ornus),
E’ interessante notare che alcune piante spinose “moderne”, come la robinia o acacia (Robinia pseudoacacia) e la marruca (Paliurus spina-christi), siano sostanzialmente assenti in quest’area, segno ulteriore dell’antichità del paesaggio di cui ci occupiamo. Evidentemente le piante indigene utilizzate erano più che adeguate allo scopo a cui erano destinate. Inoltre l’ambiente non è stato trasformato e degradato al punto da aprire spazi a piante invasive come la robinia, che al contrario rinveniamo lungo le strade più recenti, realizzate nel secondo dopoguerra, che si rivelano notevolmente “inquinanti” anche dal punto di vista dell’introduzione di specie esotiche.
Tra le specie spinose indigene un ruolo di rilievo, non solo per lo scopo difensivo che avevano ma anche per la loro valenza ecologica, spetta a prugnoli e biancospini. In proposito sul finire del Settecento il naturalista Paolo Spadoni aveva dedicato una dissertazione proprio sullo “spino bianco”, circa il modo di coltivarlo e di utilizzarlo per le “siepi vive”. Lo stesso Spadoni è stato uno dei primi naturalisti italiani a distinguere due specie diverse tra i biancospini spontanei, basandosi in particolare sul diverso numero degli stili e dei semi: Crataegus monogyna ha uno stilo e un seme, mentre C. laevigata ha 2 stili e due semi. Sul Massiccio del Catria sono presenti entrambe le specie, con distribuzione ben diversificata: Crataegus monogyna è in genere più numerosa e diffusa prevalentemente nel piano basale, mentre C. laevigata è concentrata perlopiù nel piano montano.
Ulteriori tracce delle passate attività agricole montane, meno appariscenti di alberi e arbusti, si trovano nella flora erbacea del massiccio del Catria. Nelle stesse aree di diffusione di Cese e Ranchi, o non lontano da esse, è interessante notare la presenza di un contingente floristico che da millenni forma il corteggio selvatico delle piante coltivate. Tuttora si trovano sul Catria diverse specie dette segetali o messicole, alcune esotiche e di introduzione antichissima (archeofite). Esse sono considerate infestanti, anche se negli ultimi decenni molte sono in declino o in via d’estinzione un po’ dappertutto, in seguito alle tecniche colturali moderne. Eppure nella parte montana del Catria se ne trovano ancora e decisamente lontane dai campi attuali. In certi casi si rinvengono popolamenti evidentemente relittuali, costituiti da poche piante relegate in piccoli siti, come nel caso di: gittaione (Agrostemma githago) e veronica agreste (Veronica agrestis). In altri casi le popolazioni sono più numerose, a volte occupano ampie superfici, oppure hanno maggior diffusione, come ad esempio: ventaglina dei campi (Aphanes arvensis), camomilla bastarda (Anthemis arvensis), euforbia sottile (Euphorbia exigua), specchio di Venere comune (Legousia speculum-veneris), specchio di Venere ondulato (Legousia hybrida), papavero a clava (Papaver dubium), viola dei campi (Viola arvensis), gladiolo dei campi (Gladiolus italicus).
La significativa presenza di questa particolare flora, apparentemente anomala in ambienti che a prima vista appaiono fortemente naturali, trova invece una limpida spiegazione nelle vicende storiche plurisecolari che abbiamo descritto finora. Insomma Cese e Ranchi anche se abbandonate e destinate all’oblio, hanno lasciato nella flora del Catria una memoria indelebile, chiara e stabile. Basta solo guardare la nostra meravigliosa montagna con gli occhi del naturalista e acuire la vista con il binocolo dello storico.
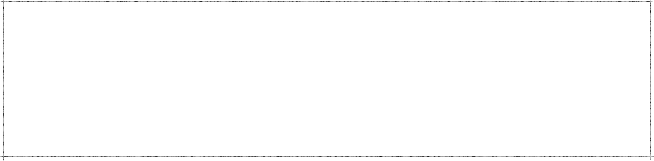
Spine, mura e fossati, il paesaggio montano a Cese e Ranchi.
Il “Bocage” dell’Appennino umbro-marchigiano, una storia da ricordare.
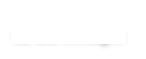
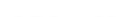

Nel paesaggio odierno delle montagne del Catria, costituito da un’alternanza di foreste e pascoli che ricorda il saltus dell’antichità e dell’alto medioevo, è venuta a mancare del tutto la presenza dell’agricoltura, uno dei tre elementi essenziali del passato tessuto economico di questo territorio. Ora sul Catria viene praticato il pascolo semibrado di bovini ed equini (pur mancando del tutto ovini, caprini e suini un tempo numerosi) e vengono prelevati alberi dai boschi per la produzione di legna da ardere (anche se la produzione del carbone, un tempo redditizia e capillarmente diffusa, non si effettua più). Quindi continuano ancora, pur con significative trasformazioni storiche, le antiche attività silvo-pastorali. C’è tuttavia un grande assente: infatti fino ad un secolo fa c’era una significativa presenza di appezzamenti coltivati, che si estendevano in particolare alle quote medio-basse, soprattutto nei settori meno acclivi, come lungo i fondovalle o le zone culminali sufficientemente pianeggianti.
Questa forma del territorio silvo-agro-pastorale era descritta dalle stesse popolazioni locali come un assetto a: Macchie, Cese siepi fratte e Pascoli.
Tale paesaggio era certamente presente, almeno nei suoi elementi essenziali, già nel Medioevo.
Sappiamo con certezza che nel XIV secolo, nel settore montano del Catria, la presenza dei pascoli e dei boschi era ben delineata e consolidata, anzi la localizzazione e la forma delle aree pascolive, delle selve o macchie, come dei punti di abbeverata e di alcuni sentieri, coincidevano sostanzialmente con quelli moderni.
Immediatamente dopo il Mille la stessa agricoltura, costituita anche da colture specializzate come vigneti, oliveti e alberi da frutto, si estendeva in diverse porzioni, per quanto periferiche, del massiccio montuoso del Catria.
Ad iniziare dalla fine del medioevo, le dinamiche economiche, del Ducato d’Urbino prima e dello Stato Pontificio poi, avevano condotto il territorio del Catria nel circuito delle grandi greggi transumanti, della trasformazione su larga scala della legna in carbone, della produzione di eccedenze cerealicole e della migrazione di forza lavoro. A tal proposito, nei primi secoli dell’Età Moderna, il Catria aveva subito una significativa “poderizzazione” di diverse porzioni del suo territorio montano, soprattutto nella nuova forma della mezzadria. L’ascesa verso la montagna dell’agricoltura aveva comunque trovato un freno, sia nella protezione dal disboscamento dei già ridotti lembi di foresta, sia nell’allevamento, visto che i terreni destinati al pascolo erano spesso intoccabili, poiché costituivano una considerevole fonte di reddito. Si pensi, a metà del XVII secolo, alle valutazioni economiche della Granduchessa di Toscana Vittoria della Rovere, che dal nonno Francesco Maria II, ultimo Duca d’Urbino, aveva avuto in eredità alcuni beni fondiari ubicati sulle montagne appenniniche tra Cucco e Nerone. Il reddito più significativo di questi terreni non veniva dalla legna o dalla coltivazione, bensì dalle “prime erbe” e dall’affitto dei pascoli.
Dalla fine del medioevo alla prima metà del secolo scorso, si era dunque consolidato un utilizzo per così dire “tripolare” dell’area montana del Catria, diviso tra le attività dell’allevamento, della foresta e dell’agricoltura di montagna. Nel corso dei secoli, esse sono state influenzate e modificate dal progressivo affermarsi di un’economia aperta alle dinamiche ad ampio raggio, di tipo mercantile e capitalistico, che si aggiungevano e si sovrapponevano, senza sostituirla, alla più antica economia di sussistenza, chiusa, autocentrata, tipica dell’età alto-medievale.
Le tre attività che si dividevano le risorse ambientali della montagna, non erano radicalmente distinte, anzi molto spesso si integravano: gli animali pascolavano anche nei boschi e i boschi dovevano offrire loro dei ripari, le cosiddette Riserve. Così pure i campi, finite le colture, dovevano essere aperti al libero pascolo. Al contempo l’agricoltura sfruttava i boschi per produrre strumenti e materiali, ad esempio era consentito prelevare alberi per costruire “perticari” e per chiudere Ranchi e Cese, allestendo siepi morte.
In questo quadro, il plurisecolare rapporto di tensione e integrazione tra l’agricoltura montana e i circostanti boschi e pascoli è alla base degli aspetti specifici e particolari di Cese e Ranchi, che rendono i campi coltivati che si estendevano sulle pendici montuose del Catria veramente unici.
Già il nome generico di Cese e Ranchi attribuito a questi appezzamenti agricoli testimonia da un lato la loro origine, dovuta al disboscamento e al dissodamento di aree forestali. D’altro lato con Cesa si intendeva fin dal medioevo anche la caratteristica di campi chiusi, recintati da vere e proprie opere difensive. Lo stesso termine Cesa deriverebbe dal latino concaedes. Le Cese infatti, come i castelli di metà medioevo, erano recintate da fossati, muriccioli e fitte siepi spinose. Con lo scopo di impedire agli animali, sia allevati che selvatici, come anche agli uomini, di accedere alle coltivazioni che contenevano. Dentro le Cese infatti venivano coltivati cereali ed erbe foraggere, inoltre, nelle località più idonee, erano anche presenti viti ed alberi da frutto.
La forma agraria dei campi chiusi, nel passato, è stata realizzata in diverse zone d’Italia, con caratteri diversi a seconda del momento storico e della situazione geografica. Tra Età comunale e Rinascimento, i campi chiusi erano ampiamente diffusi in buona parte d’Europa. Nell’Italia centro-settentrionale erano presenti anche in pianura e collina, a volte ben lontani dai centri abitati, tanto da far dire a Vittorio Sereni: “alle soglie del Rinascimento, questo paesaggio di campi a chiusura viva, [...] arieggia quello del bocage francese” . Tuttavia queste recinzioni vive, generalmente realizzate da proprietari privati che si contrapponevano agli antichi usi promiscui del territorio, erano situate in territori favorevoli alle pratiche agricole ed erano soprattutto rigidamente permanenti: “con siepi e fosse”, scriveva alla fine del XV secolo Michelangelo Tanaglia nel suo trattato in rima sull’agricoltura, “e’ pòstumi difendi /dagli avversari che son tutti armenti”, le chiusure dunque dovevano difendere non solo le prime erbe ma anche tutti i tagli successivi (pòstumi), senza eccezioni. Ben diversi da questi erano alcuni caratteri tipici di Cese e Ranchi: proprietà collettiva erede degli usi tradizionali, chiusura stagionale e parziale, complementarità e reciproca convivenza con pascolo e selvicoltura in un ambiente difficile come la montagna calcarea centro-appenninica. D’altra parte Cese e Ranchi non erano un un’eccezione né erano esclusivi di una piccola porzione di Appennino. Infatti questa particolare tipologia di campi chiusi di montagna era presente anche al di fuori dell’area del Catria, quantomeno in diverse zone dell’Appennino umbro-marchigiano. Li descrive e analizza diffusamente, confrontandoli con diverse tipologie di chiusure compreso il “bocage” nordeuropeo, anche il geografo Henri Desplanques, nella sua ricerca sui paesaggi rurali umbri, svolta tra 1952 e 1966. Ricordiamo infine l’ampia diffusione in diverse località appenniniche dei toponimi Cesa o Ranco.
La contiguità territoriale tra campi chiusi e castelli medievali. La sostanziale ininterrotta sopravvivenza nei secoli successivi. La vicinanza ai piccoli villaggi e paesi pedemontani, le cui comunità ne hanno acquisito l’uso e consolidato la proprietà collettiva. La vitalità, in alcuni periodi perfino espansiva, che hanno mantenuto fino ai primi del Novecento. La tensione/integrazione con la vocazione silvo-pastorale dell’ambiente montano in cui si sono sviluppate. Sono tutti caratteri che fanno di Cese e Ranchi una singolare forma di utilizzo del territorio appenninico, che potremmo definire “bocage montano umbro-marchigiano”. Modello che ha svolto il ruolo di gestione di territori marginali, economicamente difficili, tuttavia in grado di aiutare a sostenere le comunità che vi gravitavano.
Una ricognizione aerea o un’immagine satellitare mostrano ancora con una buona evidenza i resti dell’antico patchwork di boschi, cese e pascoli, un mosaico costituito da un ambiente naturale modellato dall’uomo. Dalle immagini dall’alto della dorsale di M. Roma - Castellacco si arrivano a contare una sessantina di Ranchi e Cese. Tuttavia ciò che oggi vediamo è solo una minima traccia di un passato in cui esse erano veramente numerose. Si pensi alla testimonianza del naturalista e monaco di Fonte Avellana Raffaele Piccinini, che ricorda, nella seconda metà dell’Ottocento, la presenza di Cese lungo tutto il fondovalle del Cesano: tra le Cafanne e il Castellaccio c’era la Cesa del Postiglione, il cui “muriccio di cinta” era costruito con rocce di “Rosso ammonitico”; a monte del Castellaccio, dopo i Sassi Aguzzi, c’era la Cesa di Baldone; ancora più a monte, dopo il Vaccarile, c’erano le Cese di Camillo. Lungo il Cesano erano tanto numerose da dare il nome ad un tratto di valle, denominato appunto “valle delle Cese”. Nella parallela alta valle del torrente Cinisco, la situazione non era molto diversa, ancora oggi vediamo muriccioli più o meno degradati, distendersi lungo il fondovalle o arrampicarsi sulle più ripide pendici di Monte Acuto. E’ il caso ad esempio, sotto Genga Capraia (Genga Aguzza in IGM), del Serrone di Bartolo (750-800 m), ricordato già dal XVI secolo come “tenimento di S. Bartolo”, in cui oggi osserviamo ancora il suo recinto costituito di imponenti muraglie.
Quel paesaggio non è dunque del tutto scomparso, almeno materialmente. In effetti però è caduta nell’oblio la sua funzione, ed è stata una caduta repentina, legata alla rivoluzionaria trasformazione economica, sociale e demografica, avvenuta nei due decenni successivi al secondo conflitto mondiale, che ha coinvolto le comunità dell’Appennino. Abbandonate del tutto Cese e Ranchi, un panorama complesso, frutto del lavoro di secoli, si è degradato velocemente e, ancor peggio, se n’è quasi perso il ricordo nell’arco di poche generazioni. In un recente libro, Emiliano Catena, figlio di quelle terre, dà voce alle cese abbandonate e “rimangiate dal bosco”, una delle tante voci che dal Catria gridano “la morte delle nostre radici”!
Oggi una piccola vigna lungo il fondovalle del Cesano, presso il Lago, chiusa da una fitta cortina di piante e cespugli è l’ultimo, eroico, rappresentante delle medievali “clusure terre” e delle Cese. Vale la pena di ricordarlo, perché costituisce una specie di fossile vivente paesaggistico.
Non sembra esserci un domani per Cese e Ranchi, ma nulla ci impedisce di immaginare coltivazioni di lenticchie o zafferano nel perimetro dei loro muriccioli riconsolidati e delle loro fratte rinfoltite. Il tempo dirà se è solo un sogno o una realtà futura...
[maggio 2019]
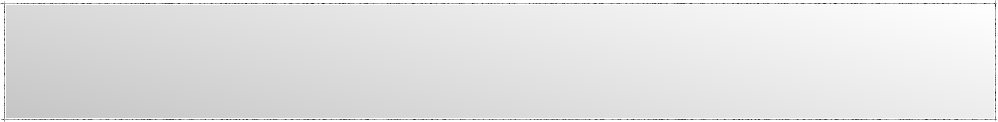
Approfondimenti e riferimenti bibliografici: Barbadoro F. 2018 ; Barbadoro D., Barbadoro F. 2008; Catena; Desplanques; Du Cange e al.; Gibelli; Marra; Pierucci 1988; Pierucci ,Polverari 1972; Spadoni 1790; Spadoni 1826-1828; Università Uomini Frontone 1908 .
Immagini: Gentile da Fabriano, Fuga in Egitto, part.,Firenze, Galleria degli Uffizi — Beato Angelico, Scene vita dei padri del desertno o Tebaide, part., Firenze, Galleria degli Uffizi — Andrea del Verrocchio, Madonna col bambino, part., Berlin, Stagtliche Museen, Gemaldgalerie.
Mappe: